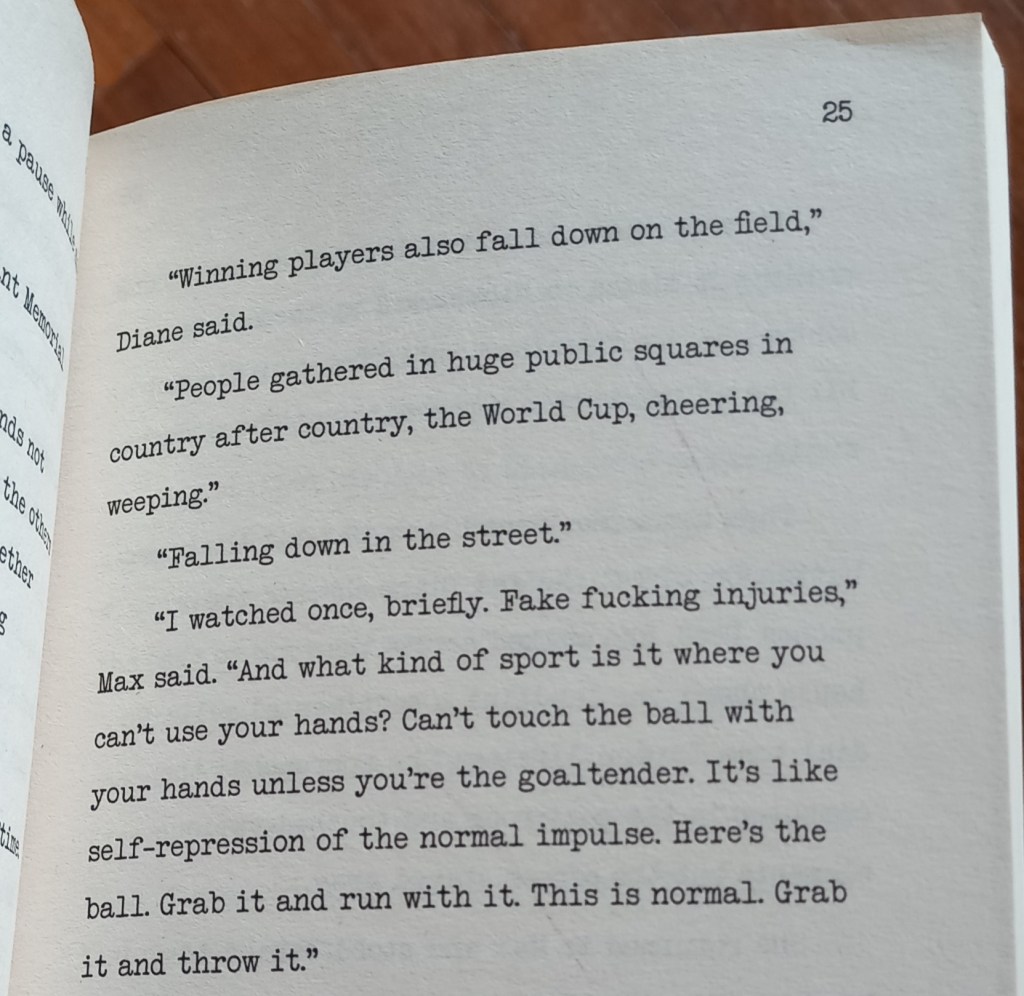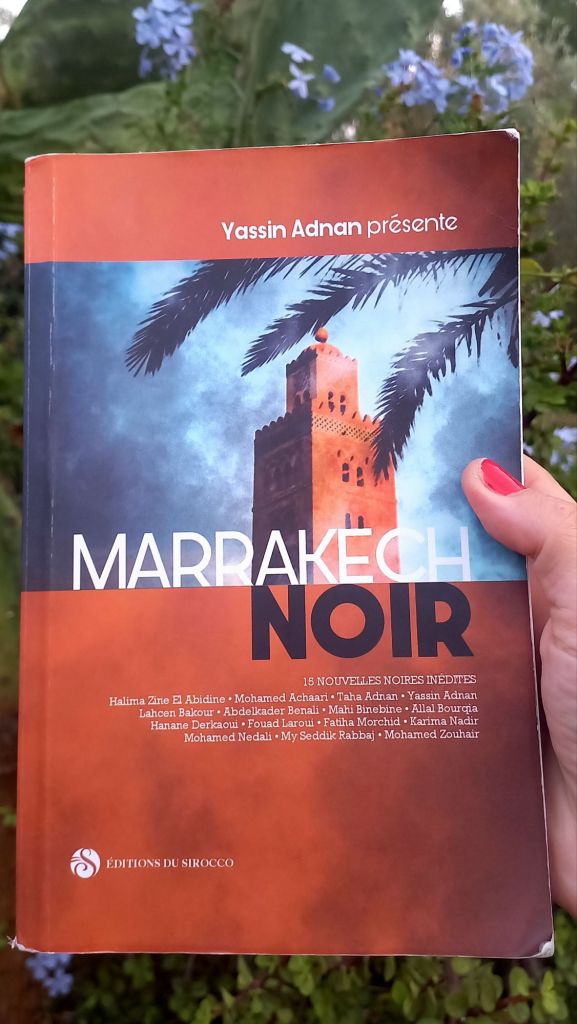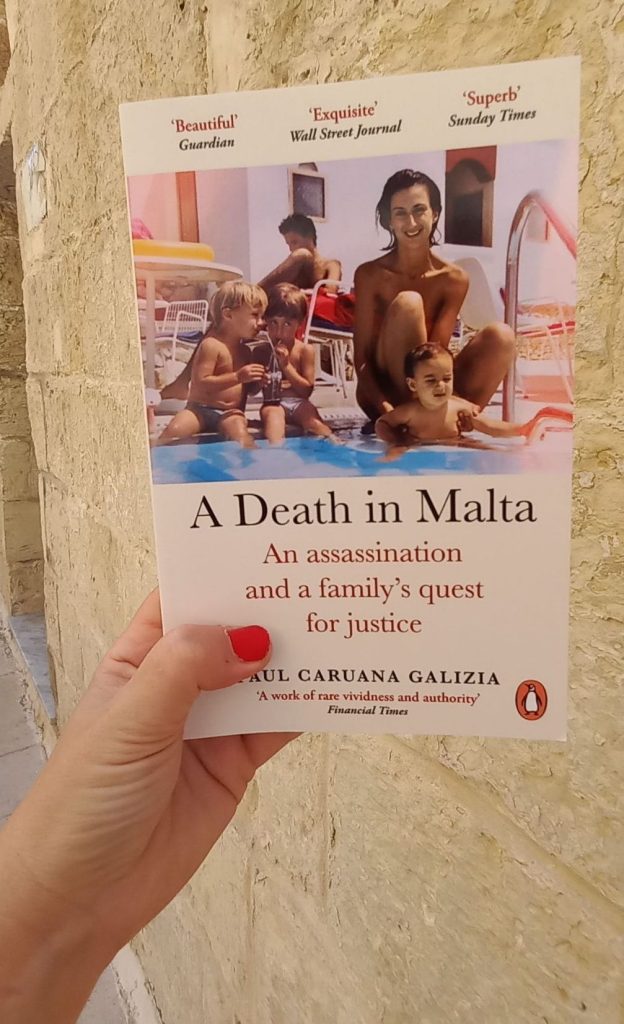Non voglio più essere forte, essere considerate forti non conviene. Con un sorriso da furfante lo confessa all’intervistatore, che non sa se crederle o meno, mentre lei si prodiga a innaffiare le piante sparse per tutta la casa, a Città del Messico, quando ormai è un’anziana signora. La grande artista britannica scomparsa nel 2011 – era nata nel 1917 – alla quale Palazzo Reale di Milano ha dedicato un’ampia retrospettiva che si conclude oggi, non ha mai smarrito il suo umorismo per le strade spesso incidentate della sua esistenza.
Si era parlato di lei anche in occasione della mostra “sorella”, ospitata anch’essa da Palazzo Reale nel 2025, dedicata all’amica artista italo-argentina Leonor Fini. Negli ultimi anni, le opere di Carrington sono felicemente tornate a essere esposte anche fuori dal Messico, paese adottivo che l’ha sempre considerata una delle sue più grandi artiste, e nel 2022 aveva già ispirato anche la Biennale d’arte di Venezia curata dall’italiana Cecilia Alemani. Edizione che fui particolarmente lieta di visitare, in una laguna appena uscita dall’incubo della Pandemia: fu la prima, infatti, in 127 anni di storia dell’istituzione veneziana, a ospitare più artiste donne che uomini. La curatrice, sulla scia delle mostre sul Surrealismo, diede ampio spazio al recupero dei lavori di artiste delle avanguardie storiche, tra cui appunto Fini e Carrington. Il titolo dell’esposizione, Il latte dei sogni, era preso in prestito proprio da una sua opera, una favola illustrata per bambini.
Ma tornando alle sue parole, quando ti dicono che sei forte, chiarisce l’artista nel bel documentario fruibile all’interno della mostra milanese – unico audiovisivo, purtroppo, presente – è soltanto per un motivo: vogliono sedersi sulla tua testa. E dal momento che qualcuno, una volta, si sedette letteralmente sulla sua testa, c’è da credere che conoscesse bene la sensazione che provoca.
Per capire la dinamica bisogna però leggere il suo bellissimo Giù in fondo, racconto autobiografico pubblicato in Francia nel 1945 con il titolo En bas, e tradotto in Italia da Ginevra Bompiani per Adelphi nel 1979, in cui ritroviamo la scena.
I due uomini, José e Santos, mi buttarono per terra alla svelta. José si sedette sulla mia testa, mentre Santos e Asegurada cercavano di tenermi ferma le membra che continuavano a divincolarsi. Mercedes, armata di una siringa che brandiva come una spada, mi conficcò un ago nella coscia.
Siamo nel 1940 e Leonora si trova in Spagna, a Santander, dove ha intrapreso, suo malgrado, uno di quei viaggi “da cui si hanno poche probabilità di tornare”, come lo definì Breton. Un viaggio al termine della notte, in cui si trova faccia a faccia con la propria follia; laggiù in fondo, in un posto che nessuno vuole chiamare con il suo nome: fuor di metafora, un reparto di psichiatria. In quel manicomio ci è arrivata, a ventitré anni, dopo che il suo amante, l’artista tedesco Max Ernst con cui viveva in Francia, è stato a sua volta trascinato in altro luogo da cui è interdetto ai più il rientro: un campo di concentramento (è la seconda volta che lo internano). Riusciranno entrambi a fuggire dalle rispettive prigioni ma si perderanno per sempre e Carrington, in seguito, con la saggezza della vecchia signora anglo-irlandese-messicana quale è poi diventata, definirà quel suo amor fou una semplice “sbronza”.
Ingabbiare la vita di Leonora Carrington nella solita logica di arte e follia, tuttavia, sarebbe da pazzi.
Innanzitutto perché il suo crollo di nervi è forse la cosa più normale e umana che sarebbe potuta accadere a una giovane donna della sua età, scampata a uno stupro da parte di una gang di soldati nella Spagna franchista. Leonora è già debilitata, in fuga dalla Francia occupata dai nazisti alla ricerca disperata di un salvacondotto, che non otterrà mai, per poter far espatriare il suo Ernst. I deliri complottistici che le hanno tolto la ragione, secondo i quali l’Europa dell’epoca sarebbe caduta sotto l’ipnosi di una congrega di maghi malvagi, spiegherebbero i fatti in modo senz’altro più accettabile, rispetto all’atroce, disumana verità storica con cui i contemporanei, e dopo di loro i posteri, si sono trovati a dover fare i conti. Alla fine di quell’esperienza, quando recupererà la lucidità, Leonora capirà che esiste un solo incantesimo per spezzare il male, la sua “ragione”.
Venni così a sapere che il Cardiazol era una semplice iniezione e non un effetto dell’ipnotismo, che don Luis non era un mago ma un bandito, che Covadonga, l’Egitto, Amachu, la Cina erano reparti dove si curavano i pazzi e che dovevo andarmene al più presto. (Etchevarria) Disoccultò il mistero che mi avvolgeva e che gli altri sembravano infittire di proposito intorno a me.
Se la malattia era stata un modo per spiegarsi, con altrettanta irrazionalità, l’abisso irrazionale in cui era sprofondato il mondo occidentale, la guarigione avviene grazie alla (ri)scoperta della lucidità: non si tratta, tuttavia, di una razionalità di tipo cartesiano, penso quindi sono, perché Carrington, la più rinascimentale di tutti i surrealisti, che appena quindicenne trascorre sei mesi di fondamentale apprendistato a Firenze, a riempirsi gli occhi delle opere dei primitivi italiani e degli artisti del primo Rinascimento come Paolo Uccello, rigetta beffarda gli assunti dell’Uomo Universale, l’Uomo vitruviano leonardesco.
Leonora, piuttosto, è la Donna Universale, come splendidamente suggerito dal ritratto in forma di collage realizzato dall’amica fotografa Kati Horna in Messico (quello che appare in apertura di questo post). È la donna che attraversa le porte di una nuova saggezza, più che conoscenza.
Per comprendere Carrington, come ben scrive la curatrice della mostra Tere Arq nel bel catalogo della mostra, è essenziale infatti “capire la distinzione che lei stessa faceva fra la conoscenza teorica (sophia) e la saggezza incarnata (gnosis) – quella linea sottile che separa lo studioso dall’iniziato”. Forte di questa saggezza, dopo l’esperienza traumatica del manicomio, alla quale riesce a sottrarsi dopo sei mesi, nonostante la sua famiglia complotti per rinchiuderla in un altro istituto, Leonora realizzerà le sue opere migliori, diventando anche dal punto di vista stilistico un’artista più matura, capace di mettere a punto una personale e raffinatissima estetica che non può essere congelata nell’unico aggettivo “surrealista” .
Nella lettera all’editore che costituisce la Prefazione a Giù in basso, in cui autorizza la pubblicazione del racconto del suo internamento a condizione che quella stessa lettera sia pubblicata come premessa dell’opera, definisce ciò che ha dire da dire “senza veli quanto è possibile”. E nella prima pagina del suo resoconto scrive:
Prima di addentrarmi nei fatti di questa esperienza, tengo a dire che la sentenza pronunciata contro di me dalla società fu probabilmente, anzi certamente, un bene perché ignoravo l’importanza della salute, cioè la necessità assoluta di avere un corpo sano per evitare il disastro nella liberazione dello spirito. E la necessità più importante ancora, che altri siano con me, che, dalle nostre conoscenze, ci alimentiamo a vicenda al fine di costituire l’Intero.
L’artista chiama in causa gli “altri”, e capiamo che non si tratta soltanto delle artiste e degli artisti a cui fu legata da innegabili affinità elettive, ma anche del lettore, della lettrice soprattutto, che legge stupefatta quelle sue memorie. La stessa lettrice che, come la sottoscritta, a distanza di decenni si interroga sulle sue opere, scrutandole da lontano. Soltanto prendendo letteralmente le distanze, infatti, è possibile cogliere il quadro che Carrington vuole rappresentare, un mondo che non esiste senza di noi: l’artista ci chiede di “accendere” la visione che ci troviamo di fronte, usando i nostri occhi per percepire, a poco a poco, tutti i dettagli della composizione, mai casuale e sempre studiatissima, e di aprire allo stesso tempo gli occhi della mente, attivando la nostra immaginazione. Soltanto in questo modo, alimentandoli, possiamo entrare nei suo mondi e farne parte (sotto, due dipinti in esposizione a Milano, Orplied, 1995 e Senza titolo- L’Arca di Noè, 1962).


A cinquantatré anni, nel 1970, in un testo pubblicato in Messico sulla rivista Cultural Correspondence, Leonora si definisce un “Female Human Animal”, un Animale Umano Femminile, sviluppando una riflessione femminista antesignana sull’identità di genere, sull’emancipazione femminile, sulla liberazione dalla tirannia della propaganda, sull’ecologia e sul superamento della visione umanista patriarcale che ha sempre messo l’uomo, l’essere umano maschile al centro, misura di tutte le cose. Il catalogo ha il merito di riproporre integralmente il testo da lei scritto in quell’occasione, poi divenuto celebre in tutto il mondo, con il titolo What is Human? , come manifesto femminista.
Sono ciò che osservo o ciò che mi osserva?
“Io sono colui che sono”, disse Dio Padre a Mosè sul monte Sinai. Questo, per me, non significa nulla.
Io sono potrebbe essere un’invenzione disonesta, che in realtà designa una moltitudine. Je pense don je suis, ma perché? Bella pretesa, Monsieur Descartes! Se la mia identità coincide con i miei pensieri, allora potrei essere qualsiasi cosa: dal brodo di pollo a un paio di forbici, un coccodrillo, un cadavere, un leopardo o una pinta di birra.
Se sono il mio corpo, allora oscillo da feto a donna di mezza età che cambia ogni secondo.
Eppure, come tutti, aspiro a un’identità, sebbene questo desiderio mi lasci sempre perplessa.
Se una vera identità individuale esiste davvero, mi piacerebbe trovarla, perché – proprio come la verità – nel momento in cui la scopri, è già svanita.
Nel 1972 Leonora Carrington disegnerà anche un poster per il movimento di liberazione femminile messicano, Mujeres conciencia, in esposizione a Milano. Peccato che, in seno all’esposizione, non si sia tuttavia trovato il modo di valorizzare questa esperienza, che sembra quasi incidentale nel percorso biografico dell’artista. Si sarebbe invece potuto connettere il vissuto di quegli anni, l’impegno intellettuale e politico di Carrington con ciò che, nel tempo, gli ha fatto eco, proponendo riflessioni filosofiche e politiche, lavori creativi e opere di altre artiste che si sono richiamate alla sua visione.
L’idea che i nostri “Padroni” abbiano ragione e debbano essere amati, onorati e obbediti è , a mio avviso, una delle menzogne più distruttive instillate nella psiche femminile. È diventato terribilmente evidente che ciò che questi “Padroni” hanno fatto al nostro pianeta e alla sua vita organica.
Credo che la vita sulla Terra abbia scarse possibilità di sopravvivere, se le donne continueranno a restare passive.
Rispetto alla mostra che Palazzo Reale ha dedicato a Max Ernst a cavallo tra il 2022 e il 2023, molto ricca ma coesa nel ricostruire, attraverso opere e documenti di vario tipo, il percorso di ricerca di un’artista così versatile, questa esposizione su Leonora Carrington non pare trovare la chiave giusta per valorizzare i pochi materiali d’archivio e le opere non visive proposti, come per esempio le rare sculture presenti, attorno alle quali non vengono creati spunti significativi di approfondimento sul lavoro scultoreo dell’artista, che fu invece molto importante nella seconda metà della sua vita.
Soprattutto nei decenni messicani, Carrington, oltre a dipingere, scolpisce sia il legno – in mostra troviamo solo il suo conturbante specchio magico nero, Magic Mirror (Sentry Figures), un’opera giovanile del 1950 – sia il bronzo, in particolare negli ultimi anni di attività (2008-2011), quando l’artrite le impedì di dipingere: in mostra troviamo soltanto una sua Goddess, Dea, del 2008. Il valore artistico delle sculture, molte delle quali sono state oggetto d’asta in tempi recenti, è tuttora dibattuto: si discute anche della “paternità”, parola che a lei non sarebbe di certo piaciuta, delle opere in bronzo realizzate nell’ultima fase. Alcuni lavori sono stati esposti finora solamente in gallerie private e da qui nasce probabilmente la difficoltà nel farle arrivare ai musei.


In Messico Carrington ha realizzato anche tessuti, maschere, gioielli e un mazzo di meravigliosi tarocchi, che l’esposizione di Palazzo Reale ha il merito di presentare al pubblico. Le ventidue carte, corrispondenti ai cosiddetti “trionfi” o arcani maggiori dei Tarocchi, furono create nel 1955 per uso privato: secondo la testimonianza di Gabriel Weisz Carrington, figlio di Leonora, la madre si dedicò per diversi anni alla pratica della cartomanzia. Fu Leonora, peraltro, a iniziare Alejandro Jodorowsky ai tarocchi marsigliesi, a cui si ispira in parte il mazzo da lei ideato (altro modello sono i tarocchi dell’artista inglese Pamela Colman Smith).
Jodorowsky ha sempre considerato Carrington una figura fondamentale nella sua formazione spirituale, come racconta nel libro autobiografico El Maestro y las magas, Il maestro e le maghe. Meno noto è che Jodorowsky e Carrington furono legati, oltre che da una lunga amicizia, da un sodalizio artistico: nel 1958 scrissero insieme un’opera teatrale a quattro atti intitolata La princesa Araña, La principessa serpente, “una disgustosa operetta surrealista per bambini mutanti” provocatoriamente indirizzata ai più piccoli, che trattava di abiezioni e assurdità varie. Rimasta segreta per quarantotto anni, fu il frutto di un gioco tra gli artisti, nella migliore tradizione surrealista.

Considerato che Carrington collaborò negli anni con molti altri artisti e artiste messicani e basati in Messico, e fu, come già menzionato, un punto di riferimento essenziale per i movimenti femministi locali, sarebbe stato interessante inquadrare la sua attività nel contesto della vita artistica e culturale di quel paese, senz’altro meno nota al pubblico italiano e forse per questo potenziale fonte di curiosità. Approfondire il contributo di Carrington alla scena messicana, così come dare maggiore rilievo al ruolo di grande maestra che ha sempre avuto e continua ad avere per le giovani artiste contemporanee a livello internazionale, non avrebbe restituito in modo più completo, e con un approccio meno eurocentrico, l’intera sua personalità artistica?
L’augurio è che questa sia la prima di nuove future esposizioni in cui il pubblico italiano possa avere la possibilità di scoprire il lavoro e il pensiero di questa grande artista, che sa parlarci del nostro presente e continua, attraverso la sua arte, a ricordarci che forse possiamo ancora cambiare rotta.
È curioso pensare che la corteccia cerebrale umana sia stata impiegata, in genere, per l’artificio, la simulazione, l’arroganza. Pretendere di essere superiore per via della nazionalità “x”; pretendere di valere più di te perché possiedo sei televisori, una casa più grande, un’auto migliore; pretendere di aver ragione perché abbiamo armi più cattive e più totalmente distruttive di quelle che hanno loro.
Perché tutta questa mortale arroganza?
Non è forse possibile usare la corteccia cerebrale per uno scopo reale e positivo, come la ricerca della verita?
Una volontà di sopravvivenza della Vita, il desiderio che il mistero continui a dispiegarsi nel mezzo della vita stessa?
L’uso straordinario e orribile del cervello umano contro altri cervelli umani è molto difficile da spiegare, ma per citare il professor Genovés, “La stessa intelligenza che ha inventato la guerra potrebbe inventare la pace” (…)